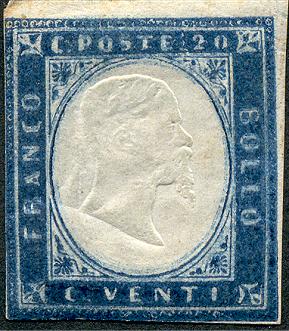|
5
centesimi
|
Verde
|
| 20 centesimi |
Azzurro
|
|
40 centesimi
|
Rosso
|
Sostituì la precedente
terza emissione man mano si esauriva. Come già avvenuto per altre serie
non esiste Decreto o Circolare ufficiale che ne sancisca la nascita (un Decreto
sarà emanato in seguito quando verranno emessi gli altri valori della
serie). Probabilmente, ancora una volta, i problemi nel distinguere i valori,
specialmente il 5 ed il 20 centesimi, nonché le diciture dei francobolli
mal leggibili della serie precedente furono la causa di questa nuova "fornitura"
di francobolli: esatto, "fornitura", in quanto per la Direzione
delle Poste di questo si trattava: semplicemente di una nuova "fornitura"
con delle variazioni rispetto alle precedenti!
Il disegno è sempre più o meno il medesimo di tutte le precedenti
emissioni, per cui non lo descriverò un'altra volta.
Successivamente si aggiunsero altri tagli alla serie, a causa delle nuove
esigenze tariffarie e precisamente:
|
10 centesimi
|
Bruno
|
Dal 1°
Gennaio 1858
|
| 80 centesimi | Arancio | Dal 1° Gennaio 1858 |
|
3 Lire
|
Rame
|
Dal 1°
Gennaio 1861
|
L'emissione è stampata
in tipografia, sempre dal Matraire, in fogli di 50 pezzi (10 file di 5), su
carta a macchina, non filigranata. A proposito della stampa tipografica, alcuni
francobolli presentano invece delle caratteristiche nettamente litografiche:
sono sorte discussioni e studi in merito a ciò. Io mi limito a dire
che i francobolli sono stampati il tipografia (e così è nella
quasi totalità dei casi) ma forse vi furono alcune provviste dove,
vuoi per "vizio" del Matraire che era pur sempre un litografo,
vuoi per la necessità di operare rapidamente, venne quantomeno mischiato
il sistema di stampa tipografico con quello litografico nel processo produttivo.
Esaminiamo ora le caratteristiche principali dei francobolli.
I francobolli misurano mm 19x21 circa. La tavola da stampa, come detto, si
componeva di 50 francobolli (solo successivamente, forse per sveltire il lavoro
venne utilizzato un sistema da stampa a 100 impronte, affiancando due pietre
da 50 esemplari). Poiché i vari cliché vennero ricavati per
duplicazione dalla matrice originale, ogni francobollo si differenzia dall'altro
per minutissimi particolari, che possono aiutare nella ricostruzione della
tavola. A questi si devono poi aggiungere i vari difetti che si vennero a
creare durante le numerosissime tirature e composizioni: limature delle cornici,
piccole ammaccature, graffi ecc. che si trovano costanti per varie forniture.
La tavola da stampa era circondata da un filetto di contorno, una lamina metallica
inserita attorno alla composizione per tenerla maggiormente stabile: secondo
alcuni autori era solo un ornamento di bellezza: ipotesi a mio avviso un po'
strana se si pensa che appena stampati i bordi dei fogli venivano tagliati
e gettati! Il filetto si trova a distanze differenti a seconda del valore
e non è presente nella composizione dell'80 centesimi e del 3 Lire;
poiché come detto i bordi venivano tagliati prima di essere distribuiti
(operazione detta di "tosatura"), tale filetto appare solo
in rarissimi casi sui francobolli (Fig. 1), mentre lo si può
rinvenire nelle prove e negli scarti di stampa (Fig 1a). Da notare
anche il fatto che spesso i singoli cliché, fissati su una tavola di
legno (anche se alcuni ritengono impossibile l'uso di questo materiale...),
non erano ben allineati o si spostavano per cui si trovano esemplari inclinati,
anche notevolmente, rispetto ai francobolli vicini (Fig 2).
 |
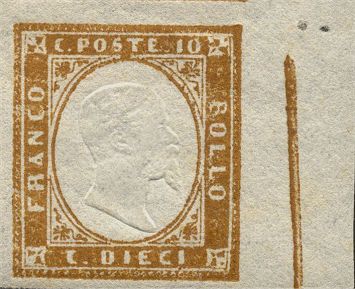 |
|
Fig.
1: riquadro di foglio a sinistra
|
Fig.
1a: riquadro destro;
scarto di stampa, con effigie falsa |

Fig. 2: coppia con netto disallineamento
Attorno alla cornice esterna dei francobolli si rinvengono sovente delle impronte, simili a filetti; tipico il caso del 40 centesimi, dove alla posizione 12 del foglio si nota sempre questo filetto pressoché completo (Fig. 3). Si tratta probabilmente dell'impronta lasciata dalle piastrine di supporto dei singoli cliché, non sufficientemente abbassate (il Rattone, nel suo fondamentale studio, ipotizza che si possa anche trattare di impronte lasciate da "cartoni tipografici" inseriti per chiudere dei "giochi" troppo ampi che si vennero a creare nella tavola da stampa).
 |
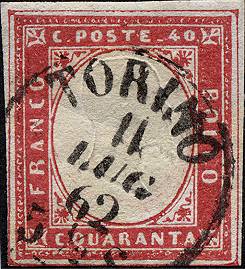 |
|
Fig.
3: un 20 ed un 40 centesimi con il filetto
esterno assai evidente
|
|
Altra piccola caratteristica di questi francobolli è che gli ornati ai quattro angoli dell'ovale non hanno distanza uguale dall'ovale stesso; in particolare quello superiore sinistro è sempre molto più distanziato degli altri (Fig. 4).
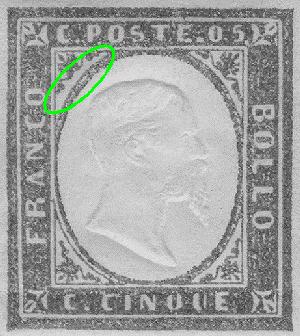
Fig. 4: l'ornato superiore
sinistro è sempre il più distante dall'ovale
Per alcuni valori (5, 10 e 20
centesimi) si possono inoltre notare dei piccoli segni peculiari di incisione,
probabilmente inseriti apposta come segni segreti per riconoscere gli originali
da eventuali falsi. Eccoli nel dettaglio.
Nel valore da 5 centesimi la linea orizzontale superiore dell'ornato interno
superiore destro non è continua (Fig. 5).
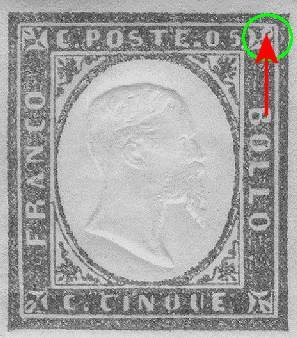
Fig. 5: il segno segreto
del 5 centesimi
Nel valore
da 10 centesimi la lettera "T" di "POSTE" è più
marcata delle altre ed anche leggerissimamente più sposta in alto (Fig.
6).
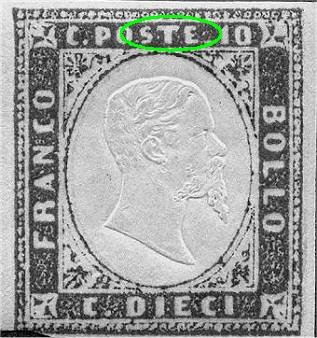
Fig. 6: il segno segreto
del 10 centesimi
Nel valore da 20 centesimi si nota un minimo intaccamento della cornice interna sotto l'ultima "O" di "BOLLO": non è sempre visibile a causa dell'inchiostrazione (Fig. 7).

Fig. 7: il segno segreto del
20 centesimi
L'effigie centrale, opera del valente incisore della Zecca Giuseppe Ferraris,
venne impressa in due differenti modi. Dapprima si procedette ad un'impressione
simultanea delle 50 impronte, fissate su una specie di matrice di stampa a
secco: ogni effigie era fissata (saldata?) su di una base metallica di circa
mm 20x22, quindi appena più grande del francobollo. Durante l'impressione
dell'effigie i vari supporti rettangolari lasciarono in maniera spesso assai
evidente la loro impronta attorno al francobollo, nei margini (Fig. 8).
Secondo altri autori l'effigie venne impressa singolarmente mediante un bilanciere
a mano (tecnicamente chiamato "stanhopes"): trovo questa
interpretazione strana, poiché avrebbe allungato notevolmente i tempi
di produzione.
I punzoni utilizzati per stampare le effigi non erano tutti identici ma alcuni
minutissimi particolari (soprattutto dell'orecchio) li differenziano; ma questo
è argomento da super-specialisti!
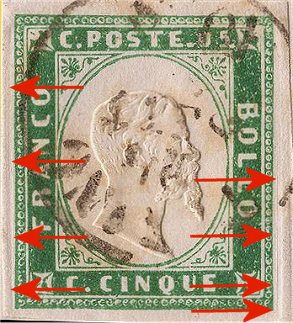 |
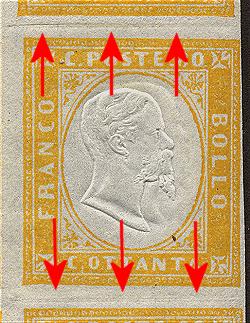 |
|
Fig.
8: l'impronta del rettangolo che
sosteneva l'effigie.
(L'80 centesimi presenta anche una nettissima doppia effigie) |
|
Con il secondo metodo,
utilizzato dal 1861-62, le testine venivano impresse a coppie orizzontali.
Questo nuovo sistema è paradossalmente controproducente in quanto più
lento del precedente: venne messo in opera originariamente per produrre i
francobolli delle Province Napoletane ma fu adottato anche su Sardegna, malgrado
la non definitiva scomparsa del primo sistema. Per altri autori invece, che
come detto ritengono che inizialmente le effigi venissero impresse singolarmente,
questo nuovo sistema velocizzava il lavoro imprimendo le testine a coppie
e non più ad una ad una. Come si può notare le idee sono spesso
in contrasto...
In merito a questo secondo sistema si pone una domanda: ma se ogni fila è
di 5 pezzi, come si fa ad imprimere le testine a coppie?
Risposta: per ogni fila si imprimevano 3 coppie di effigi; la prima battuta
sul bordo sinistro del foglio (quindi non serviva a nulla) e sul 1° esemplare,
la seconda battuta era per il 2° e 3° esemplare e la terza battuta
per il 4° e 5° esemplare.
In questo modo le testine sono allineate a coppie, tranne la prima che è
allineata con quella impressa sul bordo, che veniva poi scartato prima di
utilizzare i francobolli (si rinviene questa testina solo sulle prove o sugli
scarti di stampa)
nella Fig. 9 riproduco una striscia di 5 (la massima possibile in senso
orizzontale) in cui si nota perfettamente quanto esposto.

Fig. 9: l'allineamento a coppie dell'effigie col
secondo sistema
Come accennavo poco sopra questo
secondo sistema nacque per l'esigenza di approntare i francobolli per le Province
Napoletane ma va notato come il sistema precedente non venne del tutto abbandonato,
specialmente all'inizio.
Questo sistema a doppia effigie, che era probabilmente privo di adeguati supporti
laterali, "scaricava" però una notevole forza sulla
coppia di punzoni: alcuni di questi, con l'andar del tempo e dell'utilizzo
si incrinarono. Secondo alcuni autori (come il Damilano) si tratta in realtà
di difetti di fusione dell'acciaio dei punzoni che vennero in superficie.
Infatti, a partire dal 1862, sono visibili quelle che in gergo si definiscono
"piccola e grande incrinatura". La piccola incrinatura si
riscontra nella 1ª, 3ª e 5ª fila verticale del foglio mentre
la grande incrinatura nella 2ª e nella 4ª fila verticale. Non sono
sempre semplici da vedere, specialmente sui francobolli usati ed in particolar
modo la "piccola incrinatura". Ne do qui una riproduzione
(Fig. 10-10a). I francobolli che presentano queste caratteristica in
modo evidente sono abbastanza pregiati.
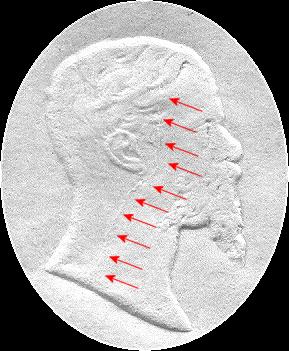 |
 |
|
Fig.
10: la grande incrinatura
|
Fig.
10a: la piccola incrinatura
|
Già che stiamo parlando
di effigi accenniamo anche alle incisioni plurime, abbastanza comuni specialmente
nelle ultime tirature, quando la produzione era massiccia e meno curata: trovare
esemplari con doppie effigi non è raro (Fig. 8); molto interessanti
sono invece i pezzi che presentano le effigi nettamente distanziate oppure
che presentano triple incisioni. Esistono anche pezzi con due effigi, una
dritta ed una capovolta: sono rarità.
Come si può vedere dalle immagini soprastanti l'orecchio presenta un
minutissimo orecchino: per alcuni studiosi (es. il Diena) è un altro
segno segreto, apposto volutamente.
Per quanto concerne la carta adoperata essa fu assai diversa, anche a causa
del lungo periodo durante il quale la serie fu in uso e per la notevole quantità
di pezzi stampati; fu sempre a macchina, bianca o bianco-avorio, senza filigrana:
la si trova spessa, sottile, porosa, levigata e via dicendo. Generalmente
andò qualitativamente peggiorando col progredire delle tirature. Ha
spessori variabili tra 4 e 10 centesimi di millimetro.
Questi francobolli ebbero svariate tirature e furono utilizzate due tavole
e varie composizioni durante gli anni (una sola per i valori da 40 ed 80 centesimi
e per il 3 Lire). Alcuni dettagli permettono di attribuire un pezzo alle varie
tavole/composizioni, anche se non sempre facilmente. Nella sezione "Approfondimenti"
viene illustrato come provare a riconoscerle.
Una nota particolare deve essere
fatta per il 3 Lire: questo valore era destinato alle altissime affrancature
che richiedevano un numero di francobolli molto elevato. Per evitare falsificazioni
vennero presi accorgimenti tecnici particolari: dopo essere stato stampato
in colore bruno-rossiccio il francobollo ancora umido veniva cosparso di polvere
metallica color bronzo-oro che si amalgamava col colore, dando il tipico aspetto
color rame (che il Decreto di emissione chiamava "oro").
Per questo valore fu usato solo il sistema di stampa delle effigi a 50 impronte
(1° tipo). Anche la stampa avvenne non con 50 pezzi affiancati a formare
la stampa ma con un unico blocco di 50 impronte. E' un francobollo assai raro,
specialmente usato e su lettera.
E veniamo ai colori: ho già accennato all'inizio come questi siano
centinaia. Il lungo periodo in cui questa emissione fu in uso, la varietà
di inchiostri utilizzati e la grande quantità di pezzi stampati, furono
la causa di una varietà di tonalità che non ha eguali nella
filatelia italiana e forse internazionale, per una singola emissione.
In merito alla catalogazione delle tinte si potrebbe disquisire per settimane.
Personalmente sono arrivato alla conclusione assurda (e personalissima,
intendiamoci!) che una catalogazione precisa di tutte le tonalità sia
impossibile ed incompletabile. Gli stessi cataloghi e manuali chiamano diversamente
francobolli identici: le sfumature, le sotto-tonalità, le ombreggiature
cromatiche, le tirature povere, ricche, antiche, e chi più ne ha più
ne metta sembrano fatte apposta per far impazzire il più calmo dei
collezionisti.
Quello che si può ragionevolmente dire è che vi sono alcune
grandi categorie di colori-base, apparse durante gli anni, nettamente
diverse tra loro: per cui anche il colore sovente aiuta a classificare la
tavola di appartenenza di un francobollo: per esempio il verde smeraldo è
facilmente identificabile ed appartiene alle prime tirature del 5 centesimi,
senza ripetersi nelle successive. Quindi l'unione colore + composizione +
carta + annullo (se databile) permette di classificare un francobollo con
relativa certezza. Ben più arduo diventa il compito quando si abbia
la volontà di interpretare correttamente le varie sfumature cromatiche.
Non ci credete? provate a prendere qualche pezzo ed a farlo esaminare da alcuni
periti differenti: scommettiamo che le risposte sulle tonalità non
concorderanno completamente?
Scherzi a parte (ma non troppo!) nelle schede dei singoli valori mi limiterò
a rappresentare le grandi famiglie di colori, senza assolutamente avventurarmi
nel terreno della specializzazione, che non sarei in grado di trattare correttamente
e che mi porterebbe soltanto a far grande confusione; anche perchè,
mai come in questo caso, due monitor differenti potrebbero rappresentare sfumature
cromatiche in maniera diversa vanificando tutti gli sforzi di rappresentazione
esatta e, perchè no, anche due persone diverse potrebbero intendere
un colore non esattamente nello stesso modo. Quindi, ad esempio, rappresenterò
per il 5 centesimi degli anni 1855-56 le tonalità verde-giallo, verde-pisello
e verde smeraldo tralasciando tutte le sfumature di chiari, scuri, pallidi,
grigiastri, tenui, cupi, carichi, vivaci, smorti, lattei, pastosi, granulosi,
vellutati, lucidi ecc. che mi limiterò ad elencare solo per completezza.